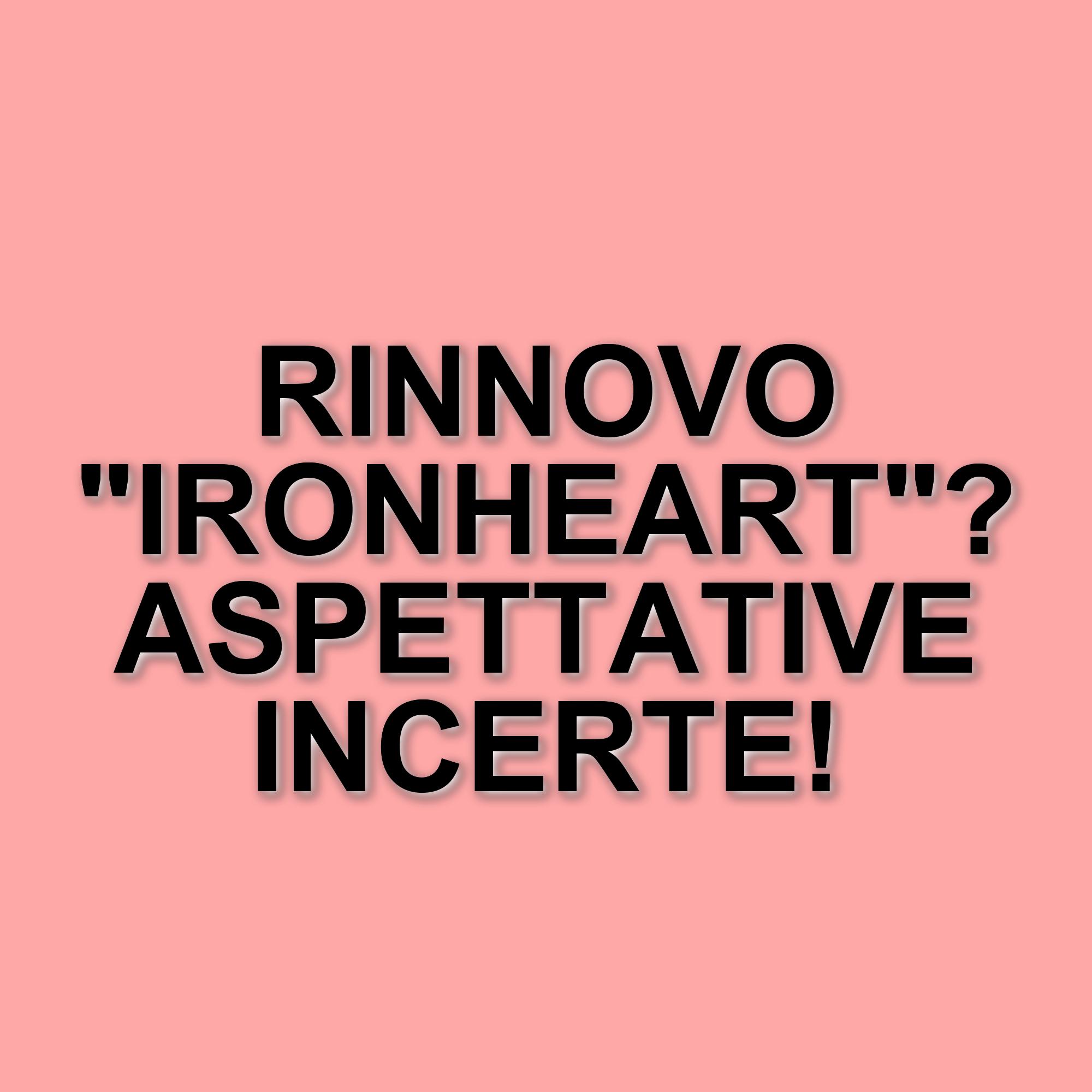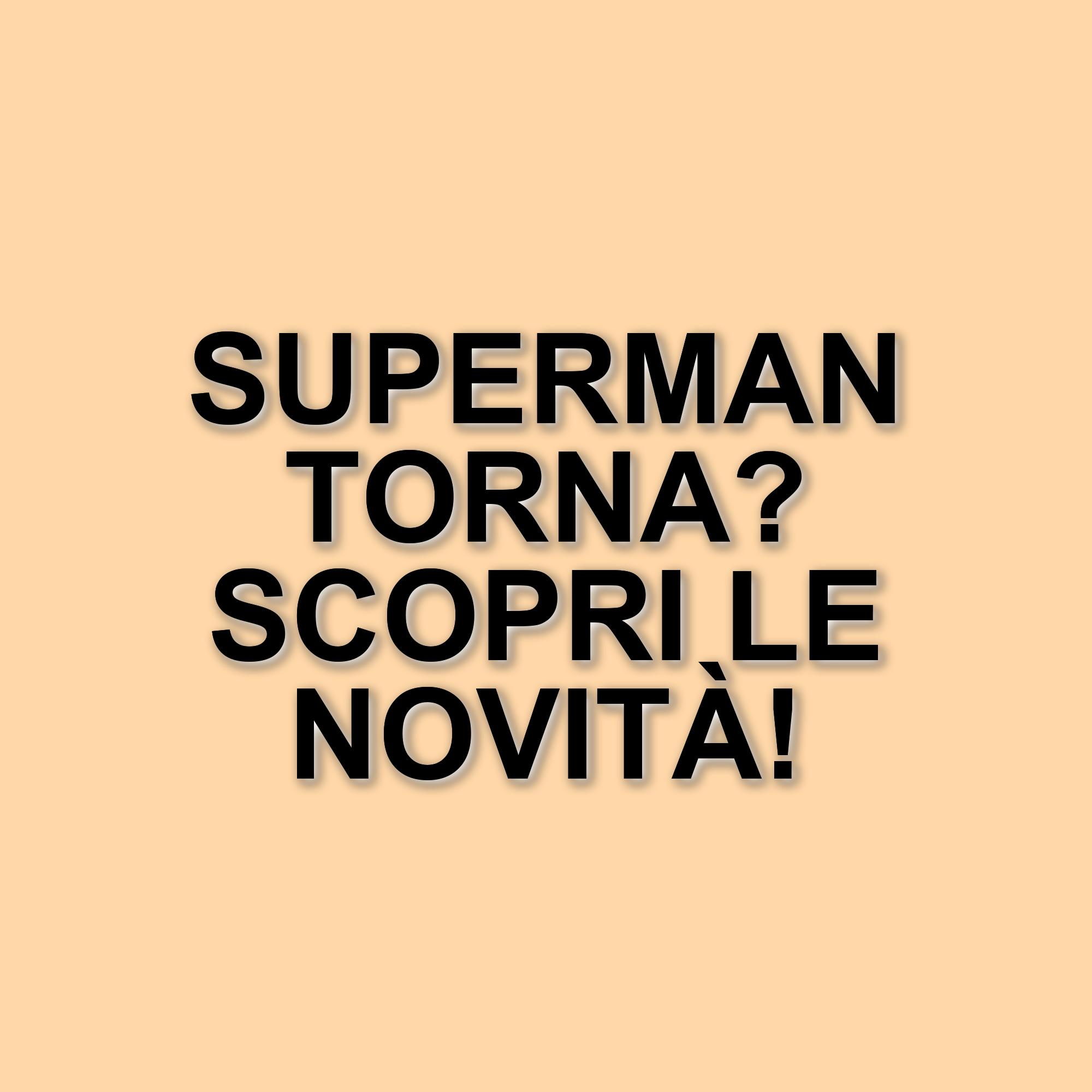Nel settimo capitolo della fortunata serie “American Horror Story” avevamo lasciato un’America devastata da ondate di violenza e paura con sentimenti contrastanti, seppur attaccata a un flebile filo di speranza. Una stagione mai come prima politicizzata, “AHS: Cult”, andata a innestarsi prepotentemente nella Storia: le elezioni statunitensi e l’era di Trump, le dinamiche torbide delle sette e dei culti, la paura come collante sociale. “American Horror Story: Apocalypse” pare lo sviluppo naturale di quel filo ormai reciso.
American Horror Story: Apocalypse – Il presente in maschera
 In Apocalypse, Murphy strizza di nuovo l’occhio alla contemporaneità; prende e camuffa un evento reale – quel falso allarme missilistico che scosse le Hawaii nel gennaio del 2018, apre la scena tra le chiacchiere spicciole di una Los Angeles indaffarata, poco prima dell’epidemia di terrore. In pochi minuti, il caos. Rimbalzano ovunque le stesse parole, appaiono sugli schermi: “Allarme nucleare, mettersi al riparo”. I notiziari riportano la distruzione di metropoli in tutto il mondo, il panico dilaga, scorrono addii piangevoli.
In Apocalypse, Murphy strizza di nuovo l’occhio alla contemporaneità; prende e camuffa un evento reale – quel falso allarme missilistico che scosse le Hawaii nel gennaio del 2018, apre la scena tra le chiacchiere spicciole di una Los Angeles indaffarata, poco prima dell’epidemia di terrore. In pochi minuti, il caos. Rimbalzano ovunque le stesse parole, appaiono sugli schermi: “Allarme nucleare, mettersi al riparo”. I notiziari riportano la distruzione di metropoli in tutto il mondo, il panico dilaga, scorrono addii piangevoli.
L’apertura è tanto più pruriginosa quando si palesano ovvietà: l’opportunità di salvezza pare schiudersi solo per Coco St. Pierre Vanderbilt (Leslie Grossman), figlia di quell’America dei grandi capitali e dell’oligarchia economica. Solo pochi altri personaggi, al limite del grottesco, verranno trascinati dalla stessa miliardaria sul proprio jet privato. In questa carrellata umana dal sapore kitsch figurano l’eccentrico parrucchiere Mr. Gallant (Evan Peters) e sua nonna Evie Gallant. C’è spazio anche per Mallory, social media manager interpretata da Billie Lourd, già al lavoro con Murphy in “AHS: Cult” e nell’inappagante “Scream Queens”. Hanno una natura quasi vignettistica le scene che il regista abbozza: piovono ovunque missili e testate nucleari, ma non è quello che più preme al fine narrativo. È solo la fine del mondo, certo, ma pur sempre l’apertura di un altro capitolo, il palesarsi dell’avenir.
American Horror Story: Apocalypse – L’inverno nucleare alle porte
L’avvenire, le cose che verranno, prendono alla fine una fisionomia ben precisa: l’inverno nucleare di un paesaggio post-apocalittico, la nebbia che si staglia tra distese di conifere (a quanto pare paesaggio–feticcio delle serie tv degli ultimi anni, tra le foreste dell’ansiogeno e nostalgico “Dark” e il meno riuscito “The Rain”). Un ultimo avamposto si erge tra le rovine, Outpost 3, sotto il diretto controllo di Wilhemina Venable (una severa Sarah Paulson in vesti vittoriane). L’ultimo rifugio utile all’uomo si rivelerà trappola infernale per gli sparuti sopravvissuti, un microcosmo claustrofobico: il pugno di ferro di Wilhemina imporrà astinenza, pochi pasti al giorno, regole rigide. Correnti sotterranee di violenza, cannibalismo, pulsioni erotiche represse alla radice – queste solo alcune delle caratteristiche dell’incubo dal sapore familiare che Murphy inscena.
La fine del mondo coincide simbolicamente anche con la negazione di ogni parità sociale. Solo due categorie all’interno dell’avamposto, netta divisione tra i “viola”, padroni, e i “grigi”, servitori. Per un anno e mezzo succubi delle politiche della direttrice, lo snodo si paleserà quando le cucine si troveranno a corto di alimenti. Rimanere corrisponde a morire, così come affrontare di petto l’inverno nucleare.
Il mordente politico, la tenaglia critica, si percepiscono nelle sfumature; Murphy abbandona momentaneamente l’intento politico e corrosivo dei precedenti episodi, per prediligere una costruzione e una cornice più appetibili. Diluisce per piacere ai più. Ha l’odore di occasione mancata il primo banco di prova di Apocalypse. Il tono farsesco che guida l’intero episodio è piacevole, fruibile, ma indora la pillola e leviga i difetti di una storia ormai più vicina ai toni di una sitcom che al brand dell’horror.
Murphy sguazza nel grottesco, mette sul carrozzone personaggi apertamente calcati e deformati, con maschere dai contorni deturpati (l’accenno è alla calca umana dei dipinti di James Ensor, spogliati della carica profondamente sovversiva). In attesa del preannunciato cross – over tra le vicende di “AHS: Murder House” e di “AHS: Coven”, ciò che rimane negli occhi dello spettatore è la sensazione che la serie si offra unicamente come guilty pleasure del momento, parentesi mordi e fuggi in un universo rapidissimo.
Simone Stirpe
20/09/2018
CONDIVIDI COI TUOI AMICI!